A 120 ANNI DALLA MORTE
Verdi, un pianista respinto
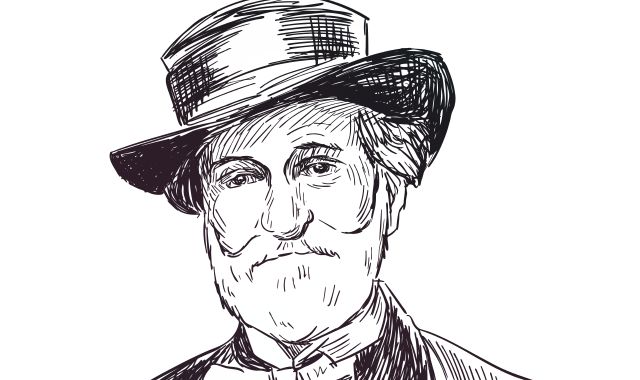
«Democratico e insieme aristocratico», lo definiva Ildebrando Pizzetti. E in Giuseppe Verdi questi due aspetti convivono, appunto.
A centovent’anni dalla morte, avvenuta a Milano il 27 gennaio 1901, lo si ricorda sì per il genio compositivo, forse il più fulgido dell’Ottocento musicale italiano, ma anche per la fortuna popolare che le sue opere hanno avuto nell’immaginario civile degli anni del Risorgimento. Perché Verdi stesso era un popolano: i suoi genitori gestivano un’osteria a Busseto, vicino a Parma, e la sua biografia sembra quasi una sceneggiatura cinematografica che vede un giovane di umili origini trovare fama e prosperità grazie al suo ingegno. Ma prima di questa fama gli ostacoli furono molti. A Busseto il giovanissimo Verdi fu posto sotto l’ala protettiva del commerciante e musicofilo Antonio Barezzi, di cui sposerà la figlia Margherita. Nel 1831, su incitamento di Barezzi, Verdi utilizzerà una borsa di studio per trasferirsi a Milano e tentare di entrare in Conservatorio. Ma all’audizione è scartato. A 18 anni è troppo vecchio e la sua tecnica pianistica è scorretta. Nel 1901 il Conservatorio di Milano sarà intitolato a suo nome, come una sorta di ammissione di colpevolezza. Intanto Verdi non si dà per vinto e nel 1839 torna a Milano per mettere in scena la sua prima opera scaligera, Oberto. Il buon successo è messo però in discussione dal fiasco dell’opera successiva, Un giorno di regno, e minato dalla morte dei due figli e della moglie. Verdi pensa seriamente di abbandonare la carriera musicale, se non che l’impresario della Scala insiste perché lavori a un libretto di Temistocle Solera, il Nabucodonosor. Sfuggitogli dalle mani, il testo si apre sui versi del Va’ pensiero. Verdi rimane emozionato da quelle parole e si decide: ne uscirà una delle pagine liriche più famose di sempre. Il Nabucco ottiene nel 1842 un successo strepitoso e apre a un cinquantennio di opere destinate a far la storia. Seguiranno i cosiddetti «anni di galera», in cui Verdi scrive tredici opere in sette anni, sostenuto dal fedele librettista Francesco Maria Piave e da una nuova compagna, la cantante Giuseppina Strepponi. Tra il 1850 e il 1853 compone la trilogia popolare: Rigoletto, Trovatore e Traviata.
Verdi dà così il via a un processo di innovazione del melodramma. I suoi interessi si dirigono verso un maggior realismo, come nella scelta del Rigoletto di dare il ruolo principale al personaggio storpio del baritono. Questa ricerca continua nei decenni successivi, passando per Don Carlos e Aida, commissionata per l’inaugurazione del Canale di Suez. Nel 1881 Verdi inizia a collaborare con Arrigo Boito, sostenitore del dramma musicale di Wagner. Il rapporto segnerà l’ultima parte della sua carriera, che si conclude con due opere shakespeariane caratterizzate da una forma sempre più libera: Otello e soprattutto Falstaff, a metà strada tra lo sperimentalismo e il divertimento buffo. Oltre alle sue composizioni, tra cui va citata la Messa da Requiem per Alessandro Manzoni, Verdi è ricordato come uno dei simboli dell’Unità d’Italia. Va’ pensiero è l’inno rinascimentale per antonomasia e celeberrimo è il motto «W Verdi». Guardò con fiducia alle Cinque Giornate di Milano, pur senza parteciparvi. E fu uomo politico: mazziniano in gioventù, folgorato poi dal carisma di Cavour ed eletto in Parlamento tra le fila della Destra storica. L’impatto della sua musica fu così potente che un necrologio in versi di D’Annunzio lo celebrò come un eroe della patria, accostandolo a Dante e Michelangelo.
© Riproduzione Riservata


