L’INCHIESTA
Le parole contano, il resto sono chiacchiere
In Italia il linguaggio nasce negli Anni Cinquanta
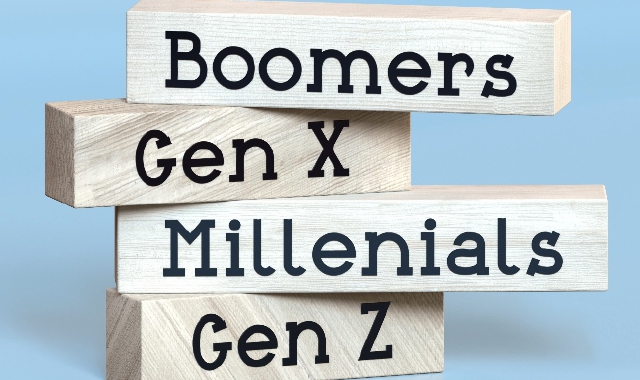
«Ho gettonato la vecchia»: era indignato il critico Ettore Allodoli nel 1951 commentando il nuovo linguaggio dei giovani. Dietro quel modo alternativo di dire “ho telefonato alla mamma” – e molti altri, come “che vasca” al posto di “che pettegola” – sosteneva vi fosse “tutta una invenzione personale di cattivo gusto snobistico e avveniristico”. E non era l’unico a pensarla così: per il grande linguista Bruno Migliorini queste “coniazioni lessicali” erano solo “mostriciattoli individuali malconiati e che per fortuna non accennano ad attecchire”. Attecchivano e cambiavano in continuazione. E forse non aveva tutti i torti Nanni Moretti in Palombella Rossa a sbraitare contro la giornalista che lo stava intervistando: «ma coma parla? Chi parla male, pensa male e vive male! Le parole sono importanti!». Chiaro: la giovane cronista aveva usato “cheap”, “kitsch” e altre raffinatezze del genere. Sarà. Ma ogni generazione ha il suo linguaggio, e spesso chi è più avanti con gli anni non lo comprende e non lo apprezza.
I RAGAZZI RIVENDICANO L’INDIPENDENZA
Per fare un solo esempio, Umberto Eco nel 2014 ricordava di non sopportare quando negli anni ‘80 lo chiamavano “Prof”: «forse che un ingegnere lo si chiama ‘ing’ e un avvocato ‘avv’?», si lamentava. Eppure, tutto sommato preferiva i neologismi al vizio degli adulti di dire sempre “e quant’altro”, invece di “e così via”. E fortunatamente era tramontato “attimino”: meglio i vezzi linguistici che l’uso improprio dell’italiano, sentenziava. Secondo gli studiosi i linguaggi giovanili nascono proprio per indicare e rivendicare un’indipendenza dal mondo degli adulti. Sono un segno di emancipazione identitaria: circoscrivono l’appartenenza a un gruppo e delimitano lo stesso gruppo nei confronti degli “altri”. Inoltre, hanno una funzione ludica – che si manifesta attraverso la deformazione e l’ibridazione dei materiali linguistici – e, infine, ricoprono un valore di “autoaffermazione” del ragazzo nella sua comunità. Insomma, alla base vi sono «motivazioni psichiche vicine a pulsioni narcisistiche miste a ribellione e nostalgia», ha riassunto Edgar Radke, forse il più noto ricercatore di questi temi. Il fenomeno è mondiale. Si verifica in ogni Paese e in ogni generazione. In Italia il linguaggio giovanile si è sviluppato solo dagli anni Cinquanta. In effetti, nei decenni precedenti non vi era nemmeno una netta distinzione tra “giovani” e “non-giovani”: in un Paese povero, rurale e poco alfabetizzato, la vita degli adolescenti ricalcava sin dai primi anni quella dura dei genitori, nei campi o in fabbrica.
IL CAMBIAMENTO SEGUE LA STORIA
Poi, dopo la guerra, con l’urbanizzazione, la scolarizzazione e il benessere degli anni ‘50, irrompe una nuova generazione. Nascono i “giovani” come categoria sociale e sviluppano un loro lessico, diffuso ad esempio dal romanzo Vitellini di città di Renzo Barbieri del 1954. Quelle espressioni oggi appaiono anche ingenue, ma facevano inorridire Allodoli: “simpaminizza la ghenga” per definire un ragazzo carismatico, “gli ho detto di fischiarmi la pace” per andarsene (dal francese “ficher la paix”), fino a “ganzo”, uno sveglio. Così, grazie anche all’unificazione linguistica spinta dalla Tv, il linguaggio segue la storia del Paese nelle sue diverse fasi. Nuovo decennio, nuovi giovani, nuovi espressioni: non si fa benzina all’auto, ma si “dà la biada al ferro”. Poi, con il ‘68 e la contestazione studentesca fiorisce il “sinistrese”. È tutto un ampolloso richiamo all’ideologia: nei discorsi il problema è “strutturale”, la “mozione è di base”, la “controinformazione” aiuta la “presa di coscienza di classe”. La frase inizia spesso con “cioè” e “dalla misura in cui”. Negli anni Ottanta arriva il “riflusso” nel privato, l’edonismo e il distacco dalla politica. Il mondo giovanile si divide in subculture e gruppi diversi: dai punk ai dark, dai paninari ai metallari. Ognuno ha il suo abbigliamento e la sua musica. E il gergo attinge dalla musica, dalla sessualità, da altre lingue. Anche dalla pubblicità: la risposta classica alla domanda “è nuovo?”– riferita a qualsiasi cosa – è “No, lavato con Perlana”, e a scuola, al “Silenzio!” intimato dal professore, dal fondo dell’aula qualcuno – sempre – sussurra “parla Agnesi”, preso dalla ditta della pasta. Mentre “CBCR” guarda al futuro: “cresci bene che ripasso”. Ma soprattutto, trainato dalle Radio private e dalla Tv – si pensi al “Drive In” – diventa un caso di studio il linguaggio dei “paninari”: il “gallo di Dio” è il leader del gruppo, i “china” (si pronuncia “ciaina”) quelli di sinistra, non si mangia ma si “smeriglia il gargarozzo” e uno in gamba è “ramboso”.
C’È CHI SORRIDE E CHI RABBRIVIDISCE
Infine, caduto il Muro di Berlino, il lessico guarda ai movimenti no-global e pacifisti e compaiono i cybergruppi e gli hackers. La rete, la connessione continua, i social e i videogiochi favoriscono la velocità e il proliferare di termini anglofili, informatici e standardizzati, da scrollare e nickname a quelli brevi e quasi cifrati: xké e non perché, cpt per capito, tvb per ti voglio bene. Nino Bixio però, per qualche studente poco preparato, è diventato Nino Biperio. Oggi molti restano allibiti di fronte agli inglesismi, al gergo da strada e alla cadenza arabeggiante che si sente in città. È un linguaggio trascurato nell’articolazione, non poco tendente al “volgareggiante” ma anche scherzoso. C’è chi sorride e chi invece rabbrividisce nel sentire “stai nel chill” per “stai sereno”, “flexare” per “ostentare” o “smellare” per “puzzare”. Certo, sono termini iperbolici, criptici, effimeri e anche un po’ spacconi, come tra i giovani. Eppure non ha molti titoli per giudicare chi oggi – superati i “cinquanta” – negli anni Ottanta definiva “cucador” un dongiovanni, “sfitinzia” una ragazza graziosa, “cozza” una non particolarmente attraente e, soprattutto, osava proclamare senza vergogna “libidine, doppia libidine e libidine col fiocco” per certificare qualcosa di piacevole. E allora il linguaggio dei giovani si può anche definire antilingua, gergo, slang. Ma senza dubbio ha una sua creatività ed è lo specchio dei tempi: il vocabolario di ogni generazione esprime anche l’atteggiamento sociale, le dinamiche tra la persona e la collettività, tra l’omologazione e – perché no – la ribellione. Basterebbe ricordare, come scriveva Roland Barthes, che “la parola non è mai innocente” e deve essere usata con consapevolezza. Perché “le parole contano, il resto sono chiacchiere”, diceva Eugene Ionesco, il grande drammaturgo. Era nato nel 1909: altro che Boomer, lui rappresentava la “Greatest Generation”.
© Riproduzione Riservata


